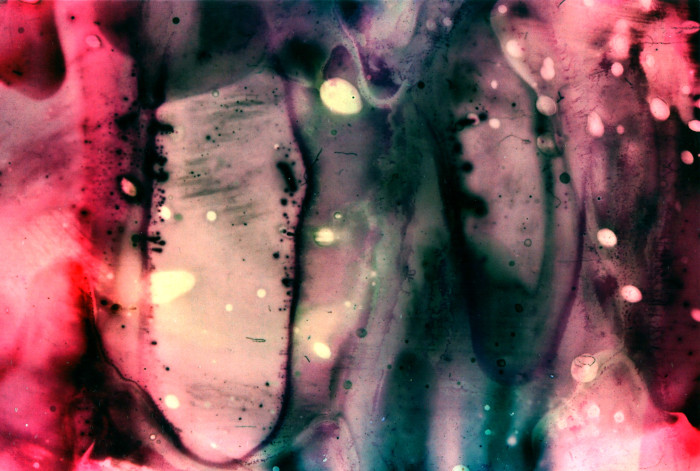Per certi versi simile all'avventura dell'Inca Tupac Yupanqui è la storia di Chepo, un indio della stirpe dei Changos, pescatori cileni che vivevano in condizioni di estrema miseria. Tanto dura era la loro permanenza sulla Terra che non riuscivano ad accedere a sufficienti risorse di acqua potabile e si dissetavano bevendo il sangue dei leoni marini; a quanto è riportato i cagnotti si nutrivano dei coaguli che imbrattavano il loro volto e scavavano nella pelle coriacea. Chepo raccontò di aver compiuto un viaggio in mare aperto con la sua zattera rudimentale, navigando per nove settimane fino a raggiungere un'isola deserta chiamata Coatu. Da quell'isola, dopo altre due settimane di viaggio sarebbe giunto fino a due isole abitate, chiamate Qüen e Acabana. Gli isolani, stando al suo racconto, sarebbero state genti ricche, dotate di vesti finissime, di greggi di lama e di grande abbondanza di oro, che offrivano al loro idolo. Chepo specificò che tali genti parlavano la lingua di don Sebastian Camanchac, ossia l'originaria lingua dei Changos, purtroppo estinta nel XVIII secolo e sostituita dapprima dal Mapudungun, e infine sul finire del XIX secolo dallo spagnolo. Questo idioma ci è testimoniato quasi soltanto da numerosi antroponimi nei registri parrocchiali, che però nella maggior parte dei casi sono incomprensibili e non mostrano affinità con alcun'altra lingua amerindiana. Ne ho identificati alcuni di origine Quechua e altri presi a prestito dal Kunza, l'antica lingua di Atacama. Riporto un elenco di antroponimi dei Changos, specificandone anche il genere.
Maschili:
Alaguana
Alagues
Alicantir
Alicanto
Aychil
Caichuca
Cancota
Cherrepe
Chiquin
Cholotinti "Cagnaccio-Locusta" (*)
Coquillo
Cutaipi
Galopin
Jalague
Lacmor
Laicor
Lamza
Liguacho
Melique
Quichan
Sacaia
Sajaya
Sanpalasi
Suiç
Tinticaur "Colle della Locusta" (**)
Tocotinti "Gufo-Locusta" (**)
Yllagues
Alagues
Alicantir
Alicanto
Aychil
Caichuca
Cancota
Cherrepe
Chiquin
Cholotinti "Cagnaccio-Locusta" (*)
Coquillo
Cutaipi
Galopin
Jalague
Lacmor
Laicor
Lamza
Liguacho
Melique
Quichan
Sacaia
Sajaya
Sanpalasi
Suiç
Tinticaur "Colle della Locusta" (**)
Tocotinti "Gufo-Locusta" (**)
Yllagues
Femminili:
Ala
Allupin
Anchuña
Cañal
Caqui
Cayani
Cola
Colamar "Luogo delle Pernici" (**)
Gosan
Gualila
Jaguaña
Jañuco
Lenca
Llancha
Ñaypul
Oja
Pocalche
Puisnes
Pulo
Puñota
Sacalla
Sailaguari
Sailapa
Samaza
Unca
Ylon
Yta
Allupin
Anchuña
Cañal
Caqui
Cayani
Cola
Colamar "Luogo delle Pernici" (**)
Gosan
Gualila
Jaguaña
Jañuco
Lenca
Llancha
Ñaypul
Oja
Pocalche
Puisnes
Pulo
Puñota
Sacalla
Sailaguari
Sailapa
Samaza
Unca
Ylon
Yta
(*) Quechua
(**) Kunza (il lemma tinti "locusta" è comunque un prestito dal Quechua)
(**) Kunza (il lemma tinti "locusta" è comunque un prestito dal Quechua)
Questo è il testo originale in spagnolo (Collezione Egerton n. 1816, Museo Britannico, Londra, foglio 223):
“Relación muy particular dada al capitán Francisco de Cáceres* por un indio que se llama Chepo, y sería de edad de ciento quince a ciento veinte años, de las islas de Salomón, que están en la mar del Sur, con expresiones de sus nombres y el tiempo que tardaban los indios sus naturales desde el puerto de Anca y de Ilo a ellas...
“Un indio que se llama Chepo, que sería de edad de ciento quince o ciento veinte años, dijo que en todo lo que se le preguntase acerca de las dichas islas, diría la verdad, con presupuesto que si mintiese le matarían; y esto fue en tiempo del capitán Francisco de Cáceres, que procurando por dicho indio topó con él, y le dio la relación siguiente:
“Preguntado que desde donde atravesaban los indios de la dicha isla, dijo que:
“—Desde el puerto de Anca y el de Ilo.
“Preguntado que cuántos días tardaban los dichos indios en ir desde los dichos puertos a las dichas islas, dijo que:
“—Tardaban dos meses en dar en una isla despoblada que se llamaba Coatu, que tiene tres cerros altos, en donde hay muchos pájaros.
“Preguntado que cómo se llama la primera isla después de la despoblada, dijo que:
“—Se llamaba Qüen, que tiene mucha gente y el señor de ella se llama Qüentique.
“Preguntósele si había más señores, dijo que:
Otros dos se llaman Uquenique y Cauxanique.
“Preguntósele si había otras islas, y dijo que:
“Si la cual se llama Acabana.
“Preguntósele cuántos días tardaban en ir desde la isla de Qüen a la de Acabana, dijo que:
“—Díez días.
Preguntósele que cual es mayor; dijo que:
“—Acabana.
“Preguntósele si tenía algún señor la dicha isla; dijo que:
“—Si y del mismo nombre de la misma isla, y que tiene un hijo que se llama Casira, el cual gobierna y manda toda la dicha isla en lugar del padre, el cual dicho padre por su autoridad había dado el mando y facultad al dicho su hijo que gobernase la dicha isla, sin entenderse él en ella.
“Preguntósele que si habían muchos señores otros, sujetos a los dichos padre e hijo; dijo que:
“—Si, que son los señores de las primeras islas susodichas y otras que no sabe los nombres.
“Preguntósele si era mayor señor éste que Guaynacava, y dijo que:
“—Sí.
“Preguntósele que si esta isla de Acabana sabe que lo es” (o sea: si es isla o continente); “dijo que:
“—No lo sabe, porque es tan grande que no sabe si isla o tierra firme.
“Preguntado si hay ovejas, dijo que:
“—Sí, y guanacos y venados.
“Preguntósele de qué se visten, y dijo que:
—De algodón y lana.
“Preguntado que qué traen en la cabeza, dijo que:
“—Unas llantos” [¿llautos?] “como los indios chichas” [¿chinchas?].
“Preguntósele que qué traía Acabana en la cabeza, dijo que:
—Un chuco como de collas, y al derredor lleno de oro, y unas plumas encima.
“—Y, asimismo, que traía vestido —dijo— que era de lana y algodón muy galano.
“Preguntado en qué caminaba el dicho Acabana de un pueblo a otro, dijo que:
“—En unas andas, que todo el cerco de ellas y todo lo alto para guarda del sol, era de oro.
“Preguntósele de qué eran las casas en que habitaban, dijo que:
“—De tierra eran las tapias, muy bien hechas, y unas cintas que las cercaban de oro, y que los señores se sirven con oro y que no había visto plata ni la había.
“Preguntado en qué adoraban estos indios, dijo que:
“—En una guaca que tienen, y dentro de ella un bulto y persona hecha de oro.
“Preguntado qué le ofrecían, dijo que:
“—Unas piedras azules, coloradas y blancas, y mucho oro y ropa de algodón y lana de todos los colores, muy galanas y pintadas.
“Preguntado qué lenguaje tenían, dijo que:
—Sabía que entendían la lengua de D. Sebastián Camanchac.
‘‘Avisáronlo que si todo lo que había dicho era verdad, porque donde no le castigarían, y refirió ser así ut supra, y que las balsas que tenían eran de palo.
“Un indio que se llama Chepo, que sería de edad de ciento quince o ciento veinte años, dijo que en todo lo que se le preguntase acerca de las dichas islas, diría la verdad, con presupuesto que si mintiese le matarían; y esto fue en tiempo del capitán Francisco de Cáceres, que procurando por dicho indio topó con él, y le dio la relación siguiente:
“Preguntado que desde donde atravesaban los indios de la dicha isla, dijo que:
“—Desde el puerto de Anca y el de Ilo.
“Preguntado que cuántos días tardaban los dichos indios en ir desde los dichos puertos a las dichas islas, dijo que:
“—Tardaban dos meses en dar en una isla despoblada que se llamaba Coatu, que tiene tres cerros altos, en donde hay muchos pájaros.
“Preguntado que cómo se llama la primera isla después de la despoblada, dijo que:
“—Se llamaba Qüen, que tiene mucha gente y el señor de ella se llama Qüentique.
“Preguntósele si había más señores, dijo que:
Otros dos se llaman Uquenique y Cauxanique.
“Preguntósele si había otras islas, y dijo que:
“Si la cual se llama Acabana.
“Preguntósele cuántos días tardaban en ir desde la isla de Qüen a la de Acabana, dijo que:
“—Díez días.
Preguntósele que cual es mayor; dijo que:
“—Acabana.
“Preguntósele si tenía algún señor la dicha isla; dijo que:
“—Si y del mismo nombre de la misma isla, y que tiene un hijo que se llama Casira, el cual gobierna y manda toda la dicha isla en lugar del padre, el cual dicho padre por su autoridad había dado el mando y facultad al dicho su hijo que gobernase la dicha isla, sin entenderse él en ella.
“Preguntósele que si habían muchos señores otros, sujetos a los dichos padre e hijo; dijo que:
“—Si, que son los señores de las primeras islas susodichas y otras que no sabe los nombres.
“Preguntósele si era mayor señor éste que Guaynacava, y dijo que:
“—Sí.
“Preguntósele que si esta isla de Acabana sabe que lo es” (o sea: si es isla o continente); “dijo que:
“—No lo sabe, porque es tan grande que no sabe si isla o tierra firme.
“Preguntado si hay ovejas, dijo que:
“—Sí, y guanacos y venados.
“Preguntósele de qué se visten, y dijo que:
—De algodón y lana.
“Preguntado que qué traen en la cabeza, dijo que:
“—Unas llantos” [¿llautos?] “como los indios chichas” [¿chinchas?].
“Preguntósele que qué traía Acabana en la cabeza, dijo que:
—Un chuco como de collas, y al derredor lleno de oro, y unas plumas encima.
“—Y, asimismo, que traía vestido —dijo— que era de lana y algodón muy galano.
“Preguntado en qué caminaba el dicho Acabana de un pueblo a otro, dijo que:
“—En unas andas, que todo el cerco de ellas y todo lo alto para guarda del sol, era de oro.
“Preguntósele de qué eran las casas en que habitaban, dijo que:
“—De tierra eran las tapias, muy bien hechas, y unas cintas que las cercaban de oro, y que los señores se sirven con oro y que no había visto plata ni la había.
“Preguntado en qué adoraban estos indios, dijo que:
“—En una guaca que tienen, y dentro de ella un bulto y persona hecha de oro.
“Preguntado qué le ofrecían, dijo que:
“—Unas piedras azules, coloradas y blancas, y mucho oro y ropa de algodón y lana de todos los colores, muy galanas y pintadas.
“Preguntado qué lenguaje tenían, dijo que:
—Sabía que entendían la lengua de D. Sebastián Camanchac.
‘‘Avisáronlo que si todo lo que había dicho era verdad, porque donde no le castigarían, y refirió ser así ut supra, y que las balsas que tenían eran de palo.
*Altre fonti nel Web riportano Cadres. Non avendo accesso al manoscritto o a sue trascrizioni di buona qualità, non so risolvere la questione.
La spiegazione più logica è che si tratti di un viaggio, certo, ma non nell'accezione strettamente fisica del termine. In altre parole si tratterebbe di visioni causate dall'uso di qualche sostanza allucinogena. La cosa non deve stupire: è ben nota la passione che i Changos avevano per le sostanze intossicanti, l'unico genere di lusso nelle loro vite di uno squallore desolante. Arrivavano a importare foglie di coca da Atacama, e non è improbabile che usassero qualche fungo dotato di strane proprietà. Sappiamo anche che mangiavano radici chiamate coroma, termine che rimanda alla voce coro, che nella lingua Kakán dei Diaghiti indicava un'erba tossica in grado di produrre visioni. Per inciso, questa notevole voce del sostrato Kakán è tuttora viva nel Quechua di Santiago del Estero (koro è glossato "un tipo di erba"). Non sono in grado di identificare la pianta e di fornirne il nome scientifico. Questo è il brano di Juan Lozano Machuca, tratto da una sua lettera al Viceré del Perù, che riporta anche alcuni etnonimi dei Changos, al momento non analizzabili:
Junto al Cerro Escala hay 4 pueblos de indios "uros", que se llaman Palolo, Notuma, Horomita, Sochusa, gente pobre que no siembran ni cogen y que se sustentan de caza de guanacos y vicuñas, y de pescado y de raices que hay en ciénegas, que llaman "coroma".
Il fatto che i cronisti chiamassero Uros i Changos non deve stupire: si pensa che la denominazione sia stata loro attribuita per il modus vivendi che li caratterizzava, più che non per parentela genetica e linguistica effettiva con quegli Uru del Lago Titicaca che tanto ruolo ebbero nelle fantasie di Thor Heyerdahl e di Peter Kolosimo. Ad esempio si notino passi come questo, sempre di Lozano Machuca:
En la ensenada de Atacama ques donde esta el puerto, hay 400 indios pescadores "uros", que no son bautizados ni reducidos.
Dal momento che non ci fu nulla di simile a un Impero Incaico nelle Isole dei Mari del Sud, si deduce che siamo di fronte a un testo onirostorico. Le imprese di Chepo sono dunque qualcosa di molto simile ai viaggi di San Brendano, che visitò in estasi le Isole Settentrionali, estesi arcipelaghi pieni di meraviglie ma privi di qualsiasi corrispondenza con il mondo fisico. La spiegazione dovrebbe essere ricercata non soltanto nella neurochimica, ma anche nella mitologia, se si trattasse di un'impresa possibile - avendo i Changos smarrito completamente la loro cultura. Forse un giorno dagli archivi salteranno fuori dati molto interessanti che ci permetteranno di conoscere meglio quel popolo affascinante e di attribuire una parentela alla sua lingua perduta.