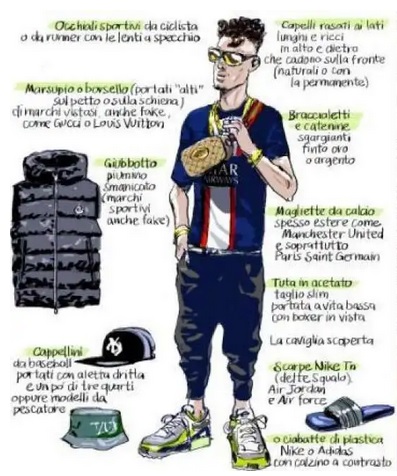ARMANNO PONGILUPO, IL SANTO CATARO
Correva l'Anno del Signore 1269, 16 dicembre, tre giorni dopo Santa Lucia. Moriva a Ferrara Armanno Pongilupo. Il suo trapasso era avvenuto in odore di santità. Dopo mesi passati nella preghiera, a confessarsi e a ricevere la comunione, il Santo si era spento. Così infatti lo conoscevano ormai dovunque nelle terre di Lombardia, e la sua fama aumentava di giorno in giorno a causa dei molti miracoli che iniziarono a registrarsi. I ciechi giunti al suo sepolcro riacquistavano la vista, gli storpi si rimettevano a camminare dopo averlo pregato. La salma fu tumulata in una cappella del Duomo di Ferrara che presto si riempì di ex voto. Un lussuoso sepolcro fu fatto arrivare da Ravenna per contenere le spoglie del Santo, e si diceva che fosse stato costruito per l'Imperatore Teodosio. A perorare la causa per la santificazione era proprio il Vescovo della città, Alberto, che aveva fama di condurre vita esemplare - cosa che all'epoca per un prelato della Chiesa di Roma era abbastanza eccezionale.
Ma chi era veramente Armanno Pongilupo? Il suo nome di famiglia (secondo altri era un soprannome) è riportato con diverse varianti: Pongilupo, Pungilupo e Punzilovo. L'ultima forma è chiaramente dialettale, essendo lovo la forma schiettamente settentrionale corrispondente al toscano lupo. Da una ricerca è risultato che non esiste al giorno d'oggi nessuno in Italia con questo cognome. Entrambi i suoi genitori erano credenti catari, e lui stesso era stato allevato nella religione dei Buoni Uomini. Aveva contratto matrimonio con una donna che era a sua volta di famiglia catara. Nel 1254 era incappato nelle maglie dell'Inquisizione: i Domenicani lo avevano imprigionato e sottoposto a tortura, costringendolo ad abiurare per aver salva la vita. Una volta tornato libero, si era subito recato a Verona dal Vescovo della Chiesa di Bagnolo San Vito, di cui era membro e si era fatto impartire il Consolamentum. Anche la moglie era una Consolata, anche se risulta che ricevette il Sacramento in una diversa circostanza. Pur aderendo formalmente al Cattolicesimo per sviare i sospetti dell'occhiuto apparato burocratico pontificio, Armanno Pongilupo era uno dei membri più attivi della Chiesa Catara: si era distinto nella sua opera di assistenza di credenti e Buoni Uomini prigionieri.
Se il clero di Ferrara sosteneva Armanno Pongilupo a spada tratta e raccoglieva dovunque testimonianze sulla sua santità, si fece avanti un avvocato del diavolo: un domenicano conosciuto come Frate Aldobrandino. Armanno parlava spesso di lui ai suoi amici, definendolo un lupo rapace e dicendo che aveva fatto scempio del suo corpo: era proprio l'inquisitore che lo aveva sottoposto a torture aberranti per obbligarlo a credere nello sconcio della transustanziazione. Frate Aldobrandino era animato da un odio cieco ed assoluto: come ogni domenicano era programmato per l'annientamento totale del Catarismo, perseguito tramite la cremazione fino all'ultimo Buon Uomo, vivo o morto che fosse. Una determinazione che non aveva nulla da invidiare a quella delle SS, anzi, ancora più malvagia perché non si rivolgeva soltanto ad esseri viventi: perseguitava in egual modo anche i cadaveri! Non per nulla i Domenicani sono chiamati Cani del Signore. Sono infatti uomini perversi, assolutamente maligni, peggiori dei cani feroci. Orbene, questo frate diabolico cominciò a riportare testimonianze di spie e di canaglie, al fine di screditare il Pongilupo.
L'Inquisizione presentò così ben ventisei capi di imputazione. Tra questi vi erano i seguenti:
1) Che egli era un eretico
...
4) Che egli aveva affermato che non c'era salvezza nella Chiesa di Roma, ma solo tra gli eretici
5) Che egli parlava male del corpo di Cristo
6) Che egli diede e ricevette il Consolamentum da e a eretici secondo il loro rito
7) Che egli aveva amicizia, familiarità e conversazione con eretici
8) Che egli diceva cose eretiche, parlando male dei ministri della Chiesa, chiamandoli lupi e demoni perché perseguitavano i Buoni Uomini, cioè gli eretici
...
10) Che egli ricadde nell'eresia dopo che egli aveva giurato di obbedire all'Inquisizione
11) Che egli aveva abiurato l'eresia in precedenza nel 1254
...
13) Che egli era un messaggero per gli eretici, prendendo loro pane benedetto da eretici
...
16) Che gli eretici vennero da lui a riverirlo dopo la sua morte
Tra le testimonianze, emersero alcuni toccanti episodi che illustrano quanto Armanno Pongilupo seguisse fino in fondo l'autentica Via degli Apostoli. Quando il Consolato Martino di Campitello fu condannato al rogo, proprio a Ferrara, Armanno lo confortò e lo assistette fino all'ultimo, incarnando la pietà dell'Evangelio. Quando i boia lo posero sulla pira, non poté trattenersi oltre, ed esclamò: "Vedete, cosa sono queste azioni, bruciare questo vecchio Buon Uomo! La terra non deve sostenere quelli che fanno tali cose!"
...
4) Che egli aveva affermato che non c'era salvezza nella Chiesa di Roma, ma solo tra gli eretici
5) Che egli parlava male del corpo di Cristo
6) Che egli diede e ricevette il Consolamentum da e a eretici secondo il loro rito
7) Che egli aveva amicizia, familiarità e conversazione con eretici
8) Che egli diceva cose eretiche, parlando male dei ministri della Chiesa, chiamandoli lupi e demoni perché perseguitavano i Buoni Uomini, cioè gli eretici
...
10) Che egli ricadde nell'eresia dopo che egli aveva giurato di obbedire all'Inquisizione
11) Che egli aveva abiurato l'eresia in precedenza nel 1254
...
13) Che egli era un messaggero per gli eretici, prendendo loro pane benedetto da eretici
...
16) Che gli eretici vennero da lui a riverirlo dopo la sua morte
Tra le testimonianze, emersero alcuni toccanti episodi che illustrano quanto Armanno Pongilupo seguisse fino in fondo l'autentica Via degli Apostoli. Quando il Consolato Martino di Campitello fu condannato al rogo, proprio a Ferrara, Armanno lo confortò e lo assistette fino all'ultimo, incarnando la pietà dell'Evangelio. Quando i boia lo posero sulla pira, non poté trattenersi oltre, ed esclamò: "Vedete, cosa sono queste azioni, bruciare questo vecchio Buon Uomo! La terra non deve sostenere quelli che fanno tali cose!"
Il processo si trascinò tra alterne vicende per circa vent'anni. Iniziato nel 1270, si concluse soltanto nel 1288, la sentenza definitiva essendo pubblicata solo nel 1301. I malvagi inquisitori ebbero la meglio sul clero locale e sui devoti del Santo, ed eseguirono l'orrida sentenza. I resti del Pongilupo furono esumati di notte e dati alle fiamme, quindi le ceneri furono disperse nelle lutulente acque del Po. La cappella fu smantellata e tutti gli ex voto distrutti.
Si ricorda l'eroismo di Donna Spera, damigella del Marchese d'Este. Era una casta credente che, costretta dagli inquisitori a dir male di Armanno Pongilupo, si rifiutò di cedere alle minacce e alla forza bruta, e morì da Martire arsa sul rogo.
Questo caso illustra come la maligna Chiesa di Roma perseguitò in modo abominevole uomini la cui vita incarnava in modo totale il messaggio di Cristo, non esitando a macchiarsi dei crimini più atroci e delle colpe più indegne pur di far valere il suo potere infame, che è la Prigione di Ferro Nero. Gli atti del processo furono resi noti nel XVIII secolo da Ludovico Antonio Muratori, che però non può aver merito - in quanto si macchiò di una colpa innominabile, componendo opere piene dell'odio più belluino verso la Vera Chiesa di Dio. Egli osò chiamare Armanno Pongilupo "faina" e coprirne il ricordo di contumelie. Questo modo di esprimersi verso le vittime del carnefice pontificio, del tutto ingiustificato, dimostra soltanto la natura non umana dell'autore, appartenente al Creatore Malvagio anima e corpo.
Come ultima cosa, faccio notare come molte fonti pur autorevoli riportano erroneamente come data di morte di Armanno Pongilupo il 26 dicembre, e tra queste c'è anche Grado Merlo. Mi trovo costretto ad emendare questo errore, forse nato dalla singola cattiva battitura di un numero e poi propagatosi a dismisura. Fanno fede le testimonianze della successione di miracoli attestati nel corso del 1269 e all'inizio del 1270:
19 dicembre: Madonna Nova, figlia di Mainardino da Maderio, e moglie di Giovannino da Achille, della parrocchia di Santa Maria in Vado, Ferrara, ha giurato alla presenza del Sire Alberto, Vescovo di Ferrara, e dei Signori Federico, arciprete, Ferrarino, canonico, e del nobile Aldigerio Fontana, di Petrocino Menabuoi, di suo figlio Pietro e di molti altri, di dire la verità a proposito della sua infermità e della sua cura, confermando sotto giuramento, che ella ha sofferto per circa nove anni nel suo occhi destro e che da circa otto giorni la tumefazione e il dolore in quell'occhio sono cresciuti, al punto che ella non poteva più vedere. E oggi è venuta di persona alla cattedrale, dove giace il corpo di Armanno, l'Uomo di Dio, e tre volte con devozione si è inginocchiata davanti alla sua tomba, devotamente pregando Dio Padre, affinché attraverso i meriti di Armanno potesse curarla della sua infermità e restituirle la vista. Avendo detto ciò, ella fece un'offerta e presto la tumefazione è svanita ed ha recuperato la vista.
Lo stesso giorno, alla presenza della sopracitata testimone, Gisla, vedova di Castellano, della parrocchia di Santa Maria in Vado, una testimone giurata, ha detto sotto giuramento che aveva conosciuto Nova da sette anni, e che aveva visto l'afflizione del suo occhio.
20 dicembre: Gisla, in precedenza di Lendinara, moglie di Stefano da Villanova, che vive nella parrocchia di Borgonuovo, ha giurato alla presenza del Signor vescovo, del Sire Federico arciprete, di Amedeo e di Ferrarino canonici, del cappellano Alberto e del mansionario Cossa, e su giuramento ha detto che per diciotto anni è stata storpia nel suo braccio destri, fino a oggi, e che non era in grado di sollevarlo fino alla bocca, e neppure di stringere qualcosa. E oggi ha fatto voto a Dio e al Beato Armanno che offrirà sulla sua tomba un braccio di cera e una candela della forma di una donna anziana, e che durante la sua vigilia digiunerà per il resto della sua vita a pane e acqua, e veglierà sulla tomba quella notte. E, avendo formalmente fatto questo voto, essa è venuta alla tomba del Beato Armanno e ha vegliato tutta notte in pura devozione e reverenza. E questa mattina, mentre il corpo di Cristo veniva elevato dal prete della cattedrale, Gisla, che era ancora lì, stette in reverenza ed ha alzato entrambe le sue braccia ed è stata liberata dall'infermità.
28 dicembre: Marinello, calzolaio di Boccacanale, ha giurato alla presenza del Signor Vescovo e dei Signori Federico arciprete, Ferrarino e Amedeo canonici, e ha pronunciato un giuramento affermando che per diciotto mesi egli era immobilizzato a causa della gotta, dai suoi lombi ai piedi, finché non è passata la vigilia di Natale. Con difficoltà era in grado di girarsi nel letto, ed era molto tormentato nelle gambe e nelle anche, e non aveva remissione né di giorno né di notte. La vigilia di Natale, prima dell'alba, egli è stato portato alla tomba del Beato Armanno, ed è stato là supplicando in devozione tutto il giorno fino all'ora nona, pregando Dio di guarirlo dalla gotta, tramite i meriti del Beato Armanno. Quando la campana ha suonato, egli si è sentito libero dal dolore alle anche e alle gambe, e ha cominciato a camminare liberamente e senza bastone, cosa che prima non era capace di fare.
Gennaio 1270: Madonna Candiana, moglie di Petrocino di Mazzo della parrocchia di San Romano, Ferrara, alla presenza del Signor Vescovo e di molti altri, chierici e laici, ha giurato di dire la verità a proposito dell'infermità e alla guarigione di sua figlia Tommasina, di due anni, che è stata mostrata al Signor Vescovo. Sotto giuramento ella ha confermato che sua figlia è stata per quattro mesi afflitta da ulcere multiple su entrambi i lati delle sue anche, cosicché era disperata di poter avere remissione. E così elle è rimasta afflitta fino a che la vigilia di Natale non fu passata. A questo punto Candiana ha votato la sua bambina a Dio e al Beato Armanno, promettendo che se fosse stata guarita, avrebbe portato alla sua tomba un'immagine di cera con le sue fattezze. Avendo fatto questo voto, il giorno di Natale Tommasina è stata liberata, le ulcere sono state guarite. Ed ella ha mostrato le ulcere, che sono apparse totalmente guarite, al vescovo e a un gran numero di persone.
Lo stesso giorno, Mastro Enoch, medico e cittadino di Ferrara, come testimone giurato, ha asserito sotto giuramento che aveva avuto in cura quella bambina, figlia di Candiana, che era lì presente, e che aveva fatto di tutto per oltre un mese per liberarla e guarirla. Ed egli sapeva per certo che era afflitta da terribili dolori a causa delle ulcere. Quando egli ha visto che la sua infermità era incurabile, l'aveva scaricata e abbandonata, dicendo alla madre della bambina di fasciarla e fare il meglio che potesse. E questo avveniva proprio prima che il Natale fosse trascorso.
Mi auguro di cuore che la città di Ferrara presto erigerà un monumento ad Armanno Pongilupo, anche se le sue vere fattezze ci sono sconosciute.
Chi vorrebbe distruggere lo Spirito non può distruggere il Ricordo...