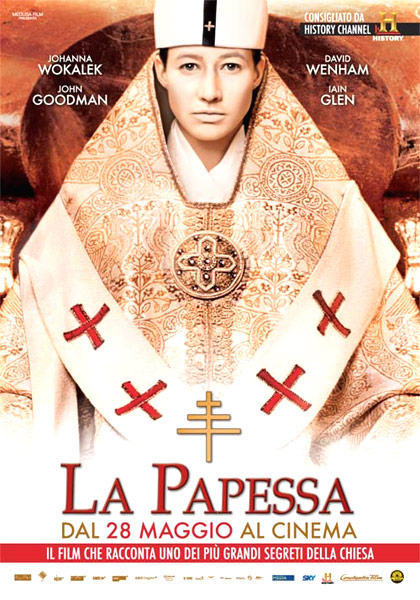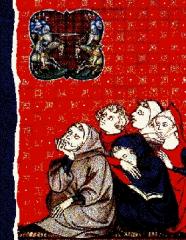Titolo originale: The Witch: A New-England Folktale
Stilizzazione: The VVitch
Stilizzazione: The VVitch
Lingua originale: Inglese, Enochiano
Paese di produzione: Stati Uniti d'America, Canada,
Regno Unito
Regno Unito
Anno: 2015
Durata: 93 min
Rapporto: 1,66:1
Genere: Orrore, storico, drammatico
Sottogenere: Stregoneria, culto satanico, dark fantasy,
horror psicologico
Regia: Robert Eggers
Sceneggiatura: Robert Eggers
Produttore: Daniel Bekerman, Lars Knudsen,
Jodi Redmond, Rodrigo Teixeira, Jay Van Hoy
Jodi Redmond, Rodrigo Teixeira, Jay Van Hoy
Produttore esecutivo: Thomas Benski,
Jonathan Bronfman, Chris Columbus,
Eleanor Columbus, Julia Godzinskaya,
Alexandra Johnes, Sophie Mas, Lucas Ochoa,
Michael Sackler, Alex Sagalchik, Lourenço Sant'Anna
Jonathan Bronfman, Chris Columbus,
Eleanor Columbus, Julia Godzinskaya,
Alexandra Johnes, Sophie Mas, Lucas Ochoa,
Michael Sackler, Alex Sagalchik, Lourenço Sant'Anna
Casa di produzione: Parts and Labour, RT Features,
Rooks Nest Entertainment, Maiden Voyage Pictures,
Mott Street Pictures, Code Red Productions,
Scythia Films, Pulse Films, Special Projects
Rooks Nest Entertainment, Maiden Voyage Pictures,
Mott Street Pictures, Code Red Productions,
Scythia Films, Pulse Films, Special Projects
Distribuzione in italiano: Universal Pictures
Fotografia: Jarin Blaschke
Montaggio: Louise Ford
Effetti speciali: Max MacDonald, Geoff D.E. Scott
Musiche: Mark Korven
Scenografia: Craig Lathrop, Andrea Kristof,
Mary Kirkland, Robert Eggers
Mary Kirkland, Robert Eggers
Costumi: Linda Muir
Trucco: Traci Loader
Interpreti e personaggi:
Anya Taylor-Joy: Thomasin
Ralph Ineson: William
Kate Dickie: Katherine
Harvey Scrimshaw: Caleb
Ellie Grainger: Mercy
Lucas Dawson: Jonas
Julian Richings: governatore
Bathsheba Garnett: strega
Sarah Stephens: giovane strega
Wahab Chaudhry: Black Phillip
Doppiatori italiani:
Lucrezia Marricchi: Thomasin
Paolo Marchese: William
Tiziana Avarista: Katherine
Mattia Fabiano: Caleb
Anita Ferraro: Mercy
Lorenzo Virgilii: Jonas
Oliviero Dinelli: governatore
Andrea Lavagnino: Black Phillip
Colonna sonora:
Colonna sonora:
1. What Went We (1:58)
2. Banished (1:52)
3. A Witch Stole Sam (2:13)
4. Hare in The Woods (1:30)
5. I Am the Witch Mercy (1:17)
6. Foster The Children (1:18)
7. Caleb is Lost (1:48)
8. Caleb's Seduction (3:05)
9. Caleb's Death (5:25)
10. William And Thomasin (2:39)
11. William's Confession (4:08)
12. The Goat And The Mayhem (3:28)
13. Follow The Goat (1:15)
14. Witches Coven (2:14)
15. Isle Of Wight (1:41)
16. Standish (2:27)
Budget: 4 milioni di dollari USBox office: 40,9 milioni di dollari US
Trama:
New England incubico. Anno del Signore 1630. Il colono inglese William viene bandito da un insediamento dei Puritani assieme alla sua famiglia – formata dalla moglie Katherine, la figlia adolescente Thomasin, il figlio preadolescente Caleb, i giovani gemelli fraterni Mercy e Jonas – a causa di una disputa religiosa. Costruiscono una fattoria vicino a una grande foresta isolata e lì Katherine dà alla luce il suo quinto figlio, Samuel. Le cose vanno male, il raccolto di mais è scarso e cattivo. Mentre è sotto le cure della biondiccia Thomasin, che fa un gioco simile al bubusettete, il piccolo Samuel scompare improvvisamente. Si scopre che una strega ha rapito e ucciso il bambino per usare il suo corpo per creare un unguento magico in grado di permettere di volare.
Devastata dalla perdita, Katherine trascorre le sue giornate piangendo e pregando. Insistendo sul fatto che un lupo abbia rapito il bambino, William porta Caleb a caccia nel bosco per trovare e uccidere il predatore. Il problema è che all'improvviso Caleb chiede al padre se Samuel, non battezzato, sia andato in Paradiso. William gli spiega che non è possibile saperlo; poi a un certo punto rivela di aver segretamente barattato la preziosa coppa d'argento di Katherine con delle provviste per la caccia. Alla fattoria, i gemelli giocano con il grosso caprone nero di famiglia, Black Phillip, che i bambini dicono parli con loro. Katherine incolpa Thomasin di aver smarrito la sua coppa d'argento e la ritiene responsabile della perdita di Samuel. Quella notte, i bambini sentono i genitori litigare sulla loro possibile morte per fame e progettano di mandare Thomasin a servire un'altra famiglia.
La mattina dopo, Thomasin e Caleb si intrufolano nella foresta per controllare una trappola. Il loro cane Fowler ("Acchiappapolli") si lancia dietro a una lepre, con Caleb all'inseguimento; il roditore spaventa il loro cavallo, che scaraventa a terra Thomasin e la fa svenire. Caleb si perde e scopre il corpo sventrato di Fowler. Addentrandosi ulteriormente nel folto, si trova davanti una baracca da cui emerge una strega, travestita da giovane donna seducente, che lo bacia. Thomasin si sveglia e trova la strada di casa seguendo la voce di William. Mentre Katherine rimprovera Thomasin per aver portato Caleb nel bosco, William la difende ammettendo a malincuore di aver venduto la coppa e di aver portato Caleb nel bosco per primo.
Quella notte, Caleb torna alla fattoria nudo, delirante e misteriosamente malato. Katherine insinua che Caleb sia caduto vittima della stregoneria e prega per lui. Il giorno dopo, il giovane è preso da violente convulsioni e vomita un'intera mela, prima di proclamare con passione il suo amore per Cristo e morire serenamente. I gemelli accusano Thomasin di praticare la stregoneria, ma lei a sua volta accusa entrambi per le loro presunte conversazioni con il capro Black Phillip e affronta il padre sulle sue intenzioni di mandarla via. Adirato per il comportamento dei suoi figli, William li rinchiude tutti nella stia delle capre.
Nel cuore della notte, i gemelli e Thomasin si svegliano e trovano la strega, che appare come una vecchia nuda, intenta a bere il sangue di una capra. La creatura malefica si gira verso di loro e ride, prima di attaccare i gemelli, mentre Thomasin osserva terrorizzata. In casa, Katherine ha una visione allucinatoria in cui Caleb e Samuel sono tornati. Prende Samuel e lo allatta; in realtà, ha esposto i seni a un corvo, che inizia a beccarle il corpo. All'alba, William trova la stalla distrutta, le capre sventrate, i gemelli scomparsi e Thomasin priva di sensi con le mani insanguinate. Mentre si muove, Black Phillip lo carica, gli perfora l'addome con le corna e lo uccide. Katherine, sconvolta, incolpa Thomasin di tutto ciò che è successo e cerca di strangolarla. Thomasin in lacrime uccide la madre, per legittima difesa, usando una roncola.
Rimasta sola, Thomasin entra nella stia delle capre e supplica Black Phillip di parlarle. La capra risponde con voce umana e le offre la vita che desidera. Quando lei accetta, lui si materializza in un bell'uomo vestito di nero, le dice di togliersi i vestiti e di firmare un libro, guidandole la mano. Egli è il Demonio. Accompagnata da Black Phillip nella sua forma di capro, Thomasin nuda entra nella foresta, dove trova una congrega di streghe, anch'esse nude, che stanno celebrando un Sabba attorno a un falò. A questo punto le streghe iniziano a levitare e Thomasin si unisce a loro, ridendo istericamente mentre sale sopra gli alberi. Non ci sono dubbi, anche se siamo di fronte all'ennesimo off-camera: ha ottenuto i suoi poteri dal Capro Nero baciandogli il deretano. Gli ha lambito le emorroidi, gli ha strusciato il naso sullo sfintere e sul perineo, inalando le scariche di gas intestinali sulfurei!
Recensione:
La narrazione si basa sulla prima ondata di panico morale che colpì le colonie britanniche in America, causando terrore isterico nei confronti della stregoneria, 62 anni prima dei famigerati processi alle cosiddette Streghe di Salem (Contea di Essex, Massachusetts, 1692). In un ambiente ostile, la coesione tra le persone nel gruppo è fondamentale per la sopravvivenza. Il singolo può certo andarsene di sua volontà o essere bandito dalla comunità, ma si troverà ad affrontare una situazione particolarmente difficile. Questo è proprio ciò che accade a William (il cognome ci è ignoto) e di conseguenza alla sua famiglia. Il regista mostra con capacità magistrali le loro spaventose condizioni di vita, in cui anche cose per noi scontate (le mele, il burro, le finestre di vetro) sono viste come sogni di un passato lontano e sepolto: quello di un'esistenza accettabile in Inghilterra. Un passato che sparisce nell'Oblio, giorno dopo giorno. La stessa luce è malata, i colori sono pallidi, si stemperano quasi in una scala di grigi. La psicologia dei personaggi è così realistica che sembra di essere proiettati in pieno XVII secolo. Una simile opera di ricostruzione ha richiesto senza dubbio sforzi considerevoli. Il risultato lo trovo eccellente. Lo consiglio vivamente a tutti.
Confini labili tra realtà e allucinazione
Eggers ha concepito questo film in modo che possa essere interpretato in due modi: letteralmente, come se la famiglia fosse assediata da vere streghe e forze sataniche, oppure figurativamente, come se la famiglia fosse sprofondata in una psicosi condivisa a causa delle circostanze difficili e delle convinzioni fanatiche. Nel film si trovano piccoli indizi che potrebbero fungere da cause plausibili dietro gli eventi, al di là dell'ovvio soprannaturale, come il cibo contaminato che causa allucinazioni, i desideri sessuali repressi e l'isolamento estremo. Il regista ha affermato che spetta allo spettatore decidere quale interpretazione sia corretta.
In una sequenza, William è raffigurato mentre tiene in mano una pannocchia marcia di mais, facendo credere allo spettatore che la muffa sia ergot, un fungo che produce un potente allucinogeno, l'ergotamina, che è riconosciuta come causa di visioni molto vivide e di isteria nei casi di stregoneria. Anche se l'ergot cresce sulla segale e su altri cereali, ma non sul mais, si è ben disposti ad accettare questo fatto improbabile come una licenza artistica.
La lepre demoniaca
Una lepre appare spesso nelle sequenze del film di Eggers, mostrando un comportamento insolito, aggressivo. Nel New England coloniale, la lepre (hare) era considerata una creatura magica a pieno titolo. Era spesso associata alle streghe, sia come "lepre del latte" (milk-hare), a cui la superstizione attribuiva il potere di rubare o rovinare il latte degli animali da fattoria, sia come incarnazione delle streghe stesse, che si credeva potessero trasformarsi in lepri per spiare e influenzare le persone. È difficile tracciare le origini precise di simili credenze, in cui verosimilmente sono confluite diverse fonti, intrecciate in modo profondo nel corso dei secoli. Storie di lepri stregate sono molto comuni nelle tradizioni della Scandinavia e del Galles. All'origine della paura popolare potrebbero esserci fattori biologici. La lepre può essere infetta e trasmettere diverse malattie gravissime, come la tularemia e la peste. Pregiudizi su questi roditori sono riscontrabili già nella Bibbia: la tradizione ebraica considera non kosher la carne di lepre e le attribuisce il potere di far diventare un pederasta l'uomo che la mangia. Altre bizzarre credenze mosaiche descrivono un potere soprannaturale della lepre, quello di generare un nuovo orifizio anale ogni anno!
Il culto del Capro Nero
Nella mitologia dei Baschi, il Capro Nero è una figura comunemente associata al Diavolo. In particolare, l'incontro magico tra streghe è chiamato Akelarre, che in Basco significa "Prato del Capro" (è un composto da aker "capro" + larre "pascolo, prato"). Francisco de Goya dipinse delle streghe e una capra nera nel 1798: l'opera è chiamata El Aquelarre. Il termine Akelarre si diffuse molto con il processo alle Streghe di Zugarramurdi, durante l'Inquisizione spagnola nel 1610, pochi anni prima di quello di Salem. In quella sentenza, alcune donne basche furono ritenute colpevoli di essere streghe e di aver partecipato a riti satanici, in tutto e per tutto simili a quelli mostrati nel film di Eggers, e furono bruciate vive. L'Inquisizione distrusse nel XVII secolo i resti dell'antica religione dei Baschi, che nelle valli più impervie erano sopravvissuti all'introduzione del Cristianesimo (un processo lungo e complesso, tra il IV e il XIII secolo).
Già nell'Aquitania è attestata in epoca romana una divinità chiamata AHERBELSTE, il cui nome significa "Capro Nero". Il sacrificio di capri e di vittime umane tra i Vascones è menzionato da Strabone. Howard Phillips Lovecraft non avrebbe avuto dubbi: si tratta del Culto di Shub-Niggurath!
Il canto in Enochiano
Verso il finale del film, le streghe che celebrano il Sabba intonano un inno in Enochiano. Il testo è quello dell'Undicesiva Chiave, che inizia così: "Oxiayal holdo od zirom o coraxo ds zildar raasy od vabzir camliax od bahal, niiso od aldon salman teloch ..." ("Il Seggio Possente gemette a gran voce e vi furono Cinque Tuoni che Volarono nell'Est e l'Aquila parlò e gridò con forte voce: Venite via! Ed essi si radunarono insieme e divennero la Casa della Morte ..."). L'intenzione del regista era quella di mostrare un'evocazione in grado di stabilire un contatto con i Morti. In realtà si tratta del testo di una cerimonia funebre. Sarei enormemente sorpreso di trovare anche una sola parola distorta della lingua Enochiana in qualche documento processuale dell'epoca.
Un breve catechismo dei Puritani
Il catechismo esposto da Eggers è in forma tipicamente dialogica:
William: Sei quindi nato peccatore?
Caleb: Sì. Sono stato concepito nel peccato e nato nell'iniquità.
William: Bene. E qual è il tuo peccato di nascita?
Caleb: Il peccato di Adamo ereditato, cioè una natura corrotta che dimora dentro di me.
William: Ricordi bene, Caleb. Molto bene. E sai dirmi che cos'è la tua natura corrotta?
Caleb: La mia natura corrotta è vacuità di grazia, propensione al peccato, solo al peccato, e così continuamente.
Segue un drammatico dialogo, densissimo di spunti di riflessione:
Segue un drammatico dialogo, densissimo di spunti di riflessione:
Caleb: Anche Samuel è nato peccatore?
William: Sì.
Caleb: Come può allora...
William: Preghiamo che sia entrato nel Regno di Dio
Caleb: Quale malvagità ha commesso?
William: Abbi fede in Dio, Caleb. Non parliamo più di tuo fratello.
Caleb: Perché? È sparito da sette giorni e poi nostra madre... non pronunciate già più il suo nome.
William: Non c'è più, Caleb.
Caleb: Ditemelo!
William: Dirti che cosa?
Caleb: È all'Inferno?
William: Caleb!
Caleb: Nostra madre non smette di pregare. E se morissi io? E se morissi quest'oggi?
Caleb: Nostra madre non smette di pregare. E se morissi io? E se morissi quest'oggi?
William: Che ti prende?
Caleb: Ho la malvagità nel cuore. Ho peccato senza perdono!
William: Sei ancora giovane.
Caleb: E se Dio non ascoltasse le mie preghiere?
William: Caleb!
Caleb: Ditemelo!
William: Ascoltami. Io ti voglio un bene smisurato, ma solo Dio e non l'uomo sa chi è figlio di Abramo e chi non lo è. Chi è buono e chi è malvagio. Vorrei poterti dire che Sam dorme in Gesù Cristo, e che lo farai anche tu. Purtroppo non posso dirtelo. Nessuno può.
Questa è la Dottrina dei Due Semi. Il punto è che è molto vicina al Cristianesimo delle origini, a quanto si trova direttamente nel Vangelo. Queste cose sono ignorate dai settari pelagiani di Comunione e Liberazione, con la loro retorica dell'Avvenimento, dell'Incontro, del Mistero et similia. Essi ritengono, come Pelagio, che l'essere umano non sia reo di nulla, che non esista la Caduta, che la Salvezza venga dalle opere. Piaccia o no, le parole di William sono filologicamente coerenti con quelle di Cristo, mentre il pelagianesimo di Luigi Giussani e dei suoi seguaci non lo è. Chi è più anticristiano, i praticanti dell'Akelarre o i giussanini? I secondi.
Altre note antropologiche
L'inconsueta ortografia VV per W nel titolo stilizzato è un semplice arcaismo. Va notato che questi segni erano usati come marchi apotropaici, derivati da Virgo Virginum ("Vergine delle Vergini"), un epiteto della Vergine Maria. Era molto diffuso nell'epoca post-medievale del XVII-XVIII secolo. Lo si trova inciso su porte, stipiti, finestre o altre parti di edifici come case e chiese, in genere in luoghi di passaggio. Si hanno casi in cui il segno si trova addirittura in grotte. La funzione protettiva di allontanamento del Male, degli spiriti immondi e della sfortuna, perdurava anche una volta che era andato perduta la memoria dell'origine religiosa.
I personaggi si accusano spesso a vicenda di "firmare il libro", e un libro viene offerto a Katherine e a Thomasin da Black Phillip, perché sia firmato. Nella teologia dei Puritani, una persona stipulava un patto con il Diavolo firmando, o lasciando il proprio segno, nel libro del Diavolo "con penna e inchiostro" o con il sangue. Solo con tale firma, secondo le credenze dell'epoca, una persona diventava effettivamente una strega e acquisiva poteri demoniaci, come apparire in forma spettrale per fare del male a un'altra persona.
La scena della morte di Caleb, e il comportamento di Jonas e Mercy mentre è in corso, si basano sui verbali del processo alle Streghe di Salem. I dispositivi legali di quell'orrido contesto consentivano l'uso di "prove spettrali". I testimoni dichiaravano che lo spirito della strega, assumendo la forma di uccelli o animali oltre che di persone, appariva davanti a loro per torturarli, ad esempio pizzicando, pungendo con aghi, mordendo, graffiando, sedendosi sul petto della vittima per impedirle di respirare, soffocandola quando cercava di recitare preghiere e inducendole convulsioni - tutti comportamenti mostrati nel film.
Curiosità tecniche
Prima del debutto alla regia di Robert Eggers con questo film, l'autore aveva realizzato solo alcuni cortometraggi. Aveva inoltre scritto una sceneggiatura, che forse non pensava neanche di utilizzare. A sua insaputa, la montatrice Louise Ford aveva passato questa sceneggiatura ai produttori Lars Knudsen e Jay Van Hoy, con cui stava lavorando all'epoca. Eggers fu inorridito da quest'azione invasiva, poiché all'epoca non considerava completa la sua sceneggiatura completa; fortunatamente i produttori la apprezzarono. Gli suggerirono di semplificarne la struttura, che in origine era divisa in cinque atti, ognuno raccontato dal punto di vista di un membro della famiglia. Quattro anni dopo, il finanziamento fu garantito e la pellicola fu realizzata.
Il film è stato girato formato 1.66:1, che ormai è raro. Il direttore della fotografia Jarin Blaschke ne ha spiegato i motivi, con un linguaggio un po' sconnesso: "Beh, è più senza tempo. È un formato che risale a molto tempo fa. Voglio dire, non si vede molto in 1.85:1 prima, sai, degli anni '50. È un formato che non si vedeva nell'arte fino a tempi molto recenti. Quella qualità senza tempo era attraente. Inoltre, mi sono affidato al mio istinto. Mi sembrava giusto. Aveva anche il vantaggio di poter rendere la casa un po' più claustrofobica e di mostrare più altezza degli alberi che incombevano sui personaggi. E si poteva comunque avere tutta la famiglia nell'inquadratura e farla funzionare".
Stephen King ha dichiarato di essere rimasto terrorizzato dalla visione di The Witch.
Il regista ha dichiarato in un'intervista che l'animale più ammaestrato del film è stato la lepre, e che anche il corvo e il cavallo sono stati abbastanza facili da gestire, mentre il caprone Black Phillip a quanto pare è stato particolarmente difficile da addestrare. Una delle scene, quella in cui Black Phillip si lancia e lotta contro il padre di famiglia, non era prevista nella sceneggiatura; tutto è successo in modo spontaneo e basta.