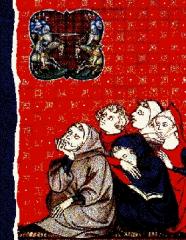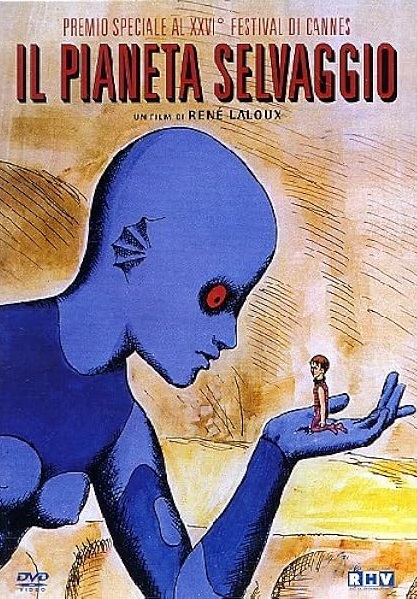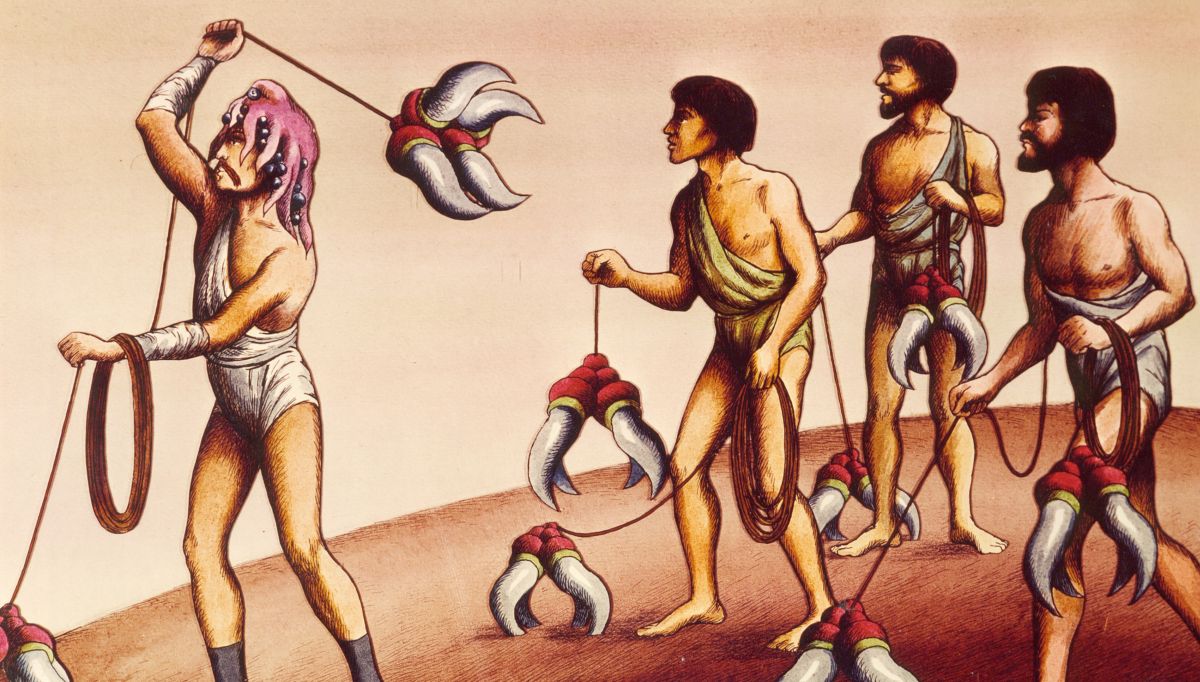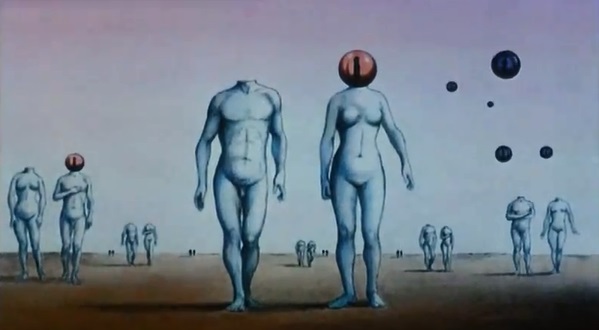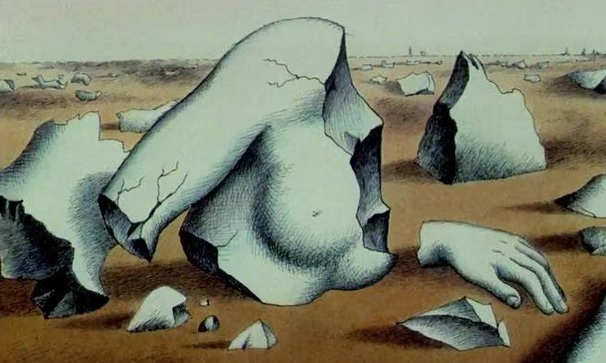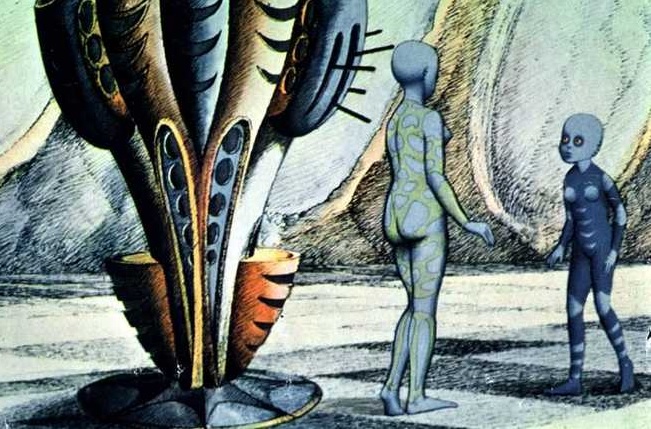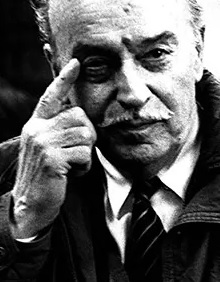L'ESPANSIONE DEL CATARISMO
IN LINGUADOCA
IN LINGUADOCA
Percorsi dualisti dalla Francia alla Linguadoca
I libri che hanno maggior successo sono quelli che presentano la realtà in chiave romanzata, deformandola in modo tale da fornire spiegazioni semplici, comprensibili da tutti anche senza una preparazione specifica.
Questo può ben spiegare come mai così pochi sanno che il Catarismo è partito dalla Francia settentrionale e dalla Renania per espandersi nelle regioni meridionali in cui ebbe una straordinaria fioritura. Perseguitati ferocemente e con maggior efficacia, i Buoni Uomini del settentrione ci hanno lasciato scarsissime tracce sulla vita delle loro comunità. La loro storia è oscura, anche se a tratti illuminata da poche testimonianze eccezionali.
Ora passiamo ad analizzare la propagazione del movimento in Linguadoca, cercando di comprendere in dettaglio le cause della sua immensa fortuna nella seconda metà del XII secolo. Per fare questo, occorre innanzitutto considerare la situazione culturale, sociale, politica e religiosa vigente nelle regioni occitaniche in quell'epoca.
Andiamo indietro nel tempo. Le modalità della conquista della Gallia Narbonese furono diverse da quelle della Celtica e della Belgica. La Provincia e la Narbonensis Prima sono state romanizzate prima delle regioni sottomesse da Cesare, ed hanno mantenuto a lungo una cultura edonistica e una tradizione di tolleranza. Mentre a meridione le genti si radevano, vestivano con la toga ed andavano a teatro, in quella che sarebbe poi stata chiamata Normandia il costume dell'antropofagia non era ancora spento in epoca imperiale. Ovviamente le cose non sono così semplici, e sbaglia chi crede a un Nord evolutosi come entità celto-germanica e barbarica schierata in modo compatto contro un Sud civilizzato e romano. Anche nella Narbonese ci furono tarde sopravvivenze di idiomi preromani e di paganesimo autoctono: al di fuori delle città costiere vivevano popolazioni montanare molto legate alle tradizioni avite. Col passare dei secoli, il latino volgare si è sviluppato in modo molto diverso nelle due aree. Mentre a nord il sostrato era gallico e il superstrato franco, a sud il sostrato era celto-ligure con influssi iberici, e il superstrato gotico. Diverse circostanze storiche avevano portato le due terre a divergere in modo significativo.
Solo per fare alcuni esempi, la parola per indicare il cane era CHIENS in oïl antico, e i suoi corrispondenti occitani erano CANS e GOS. CANS è dal latino CANIS, come l'oïl CHIENS, ma GOS è un termine di origine iberica e senza alcuna etimologia indoeuropea.
Durante i secoli della decadenza dell'Impero Romano, si diffuse dai Pirenei fino alle Alpi il Manicheismo. Ilario di Poitiers ci attesta questo, e fa riflettere anche il caso di Agostino, che prima della conversione all'ortodossia fu raccomandato al pagano Simmaco da influenti amici manichei. Sotto il dominio dei Goti il Manicheismo decadde come religione organizzata. Le sue ultime tracce documentabili sono del VI secolo, anche se sono molto probabili sopravvivenze più tarde. In ogni caso il lievito del dualismo non morì mai, e predispose le genti alle idee dei Fundaiti, e infine alle predicazioni dei missionari catari che giunsero tra loro nel XII secolo.
Non si conoscono i precisi percorsi tramite i quali questi Apostoli della Linguadoca giunsero direttamente dalla Champagne o piuttosto da qualche regione più vicina al territorio occitano. Non si sa se furono pochi esuli arrivati dopo lunghi viaggi, oppure se in molti si spostarono su distanze più modeste passandosi il testimone da un centro abitato all'altro. Una cosa non esclude necessariamente l'altra. Fatto sta che quando Bernardo di Chiaravalle intraprese un viaggio a Tolosa e ad Albi nel 1145, vi trovò l'ortodossia della Chiesa di Roma in un profondo stato di decadenza. L'anno precedente alcune lettere scritte da Evervino di Steinfeld lo avevano allarmato, descrivendogli il diffondersi di una strana eresia egualitaria e pauperista. Erano proprio i dissidenti religiosi che andavano scoprendosi dovunque, ai quali il teologo Ecberto di Schönau aveva usato per primo il nome Catari. Il clamoroso insuccesso incontrato da Bernardo di Chiaravalle lo sconvolse, perché mai si sarebbe aspettato una simile situazione: si arrivò al punto che numerosi cavalieri fecero cozzare le spade contro gli scudi per impedire al suono delle sue parole di essere udito.
L'inquisitore Anselmo di Alessandria ancora una volta ci viene in aiuto con il suo Tractatus de Hereticis. A proposito dell'Occitania, egli scrive questo:
"Item Provinciales, qui sunt confines de Francia, audientes predicationem eorum et seductis ab illis de Francia, tantum multiplicati sunt qui fecerunt iiij episcopos, scilicet episcopum de Carcasona, et albigensem, et tholosanensem et angenensium."
Ovvero:
"Così i Provenzali, che confinano con la Francia, avendo ascoltato la loro predicazione e sedotti da quelli della Francia, si moltiplicarono a tal punto che crearono 4 vescovi, ovvero il vescovo di Carcassona, di Albi, di Tolosa e di Agen."
Per Provinciales qui si intendono le genti che abitavano tra il Rodano e i Pirenei, estendendo la definizione che propriamente parlando sarebbe da attribuirsi soltanto alla parte orientale dell'Occitania, quella tra le Alpi e il Rodano.
A favorire un simile radicamento della religione dei Buoni Uomini contribuì innanzitutto la mancanza di un'autorità religiosa centrale in Linguadoca: il clero locale era labilmente legato a Roma ed era molto debole, sia sul piano etico che su quello politico. I pochi grandi feudatari erano i Conti di Tolosa, i Conti di Foix e i Visconti Trencavel, alle cui dipendenze si trovava una miriade di vassalli e di valvassori. Questa situazione confusa era un'eredità del marasma che aveva disgregato l'Impero Carolingio per dare vita a una serie di comunità autonome, alcune delle quali erano poco più che monasteri autogestiti. Nel XII secolo, l'assenza di un sistema feudale sviluppato aveva favorito il proliferare di una piccola nobiltà rurale che concupiva le rendite ecclesiastiche. Questo aveva portato a un'ostilità endemica, a un attrito tra nobili e chierici.
La gestione delle proprietà feudali non era efficiente, e la giustizia amministrata da incompetenti siniscalchi si serviva di mercenari, i famigerati ribaldi. che spesso erano un mezzo peggiore dei mali che erano incaricati di combattere. Tali sgherri compivano mille abusi ai danni della collettività ed esercitavano un latrocinio legalizzato.
È quindi comprensibile come il Catarismo si venne a trovare in un ambiente incredibilmente favorevole. Non aveva grandi esigenze materiali, in netto contrasto con la Chiesa di Roma. Non aveva bisogno di idoli, della lavorazione dei metalli preziosi, delle sfarzose vesti di porpora. Non aveva bisogno di marmi con cui erigere templi. Poteva giovarsi del clima di generale tolleranza della popolazione e dell'anticlericalismo dei nobili. Anche l'agnosticismo edonista che si andava sviluppando nelle corti aiutava non poco i missionari a diffondere il Verbo.
Il Perfetto Cataro, a differenza del prete cattolico, non condannava le persone per il loro modo di vivere. L'unico obbligo per il credente era di ricevere il Consolamentum in punto di morte. Così era possibile per un libertino essere cataro. Anzi, i rapporti con molte donne e non fini alla procreazione erano ritenuti migliori del matrimonio, che comporta la santificazione del meretricio. La soppressione della sessualità non veniva imposta a chi non era stato consolato, né si accettava che una persona fosse costretta a una simile vita senza desiderarlo o fin da giovane. I vincoli familiari erano comunque molto forti nella tradizione occitana, e favorivano il mutuo sostegno: si può citare persino il caso di un vescovo cattolico che aveva un fratello che era un Perfetto.
Il Papato sentiva la continua necessità di intromettersi perché non aveva su tali regioni lo stesso potere indiscusso che aveva altrove. Constatava il lassismo degli ecclesiastici e l'incapacità dei poteri feudali. Il contrasto tra la Linguadoca e la Champagne è stridente, come si può vedere analizzando il caso della comunità di Reims, dove la collaborazione tra potere ecclesiastico era totale. Nelle diocesi settentrionali i rapporti tra potere temporale e potere ecclesiastico erano di simbiosi: addirittura la nobiltà era così risoluta nel combattere l'eresia che spesso scavalcava i vescovi e applicava di sua iniziativa misure draconiane. Nel Mezzogiorno tutto ciò era inconcepibile, e un effetto diretto della mancanza di interesse verso la repressione dell'eresia fu la totale libertà di movimento dei Catari, che ebbero il tempo e la possibilità di organizzarsi in una Chiesa molto forte.
La superiorità morale dei Buoni Uomini rispetto agli ecclesiastici permise loro di ottenere grandi risultati nell'umanizzare le genti con cui venivano in contatto, e di questo abbiamo una testimonianza. In un sermone dall'arcivescovo di Pisa Federico Visconti, tenuto per commemorare l'opera di Domenico di Guzmán, si trovano inaspettate e preziose informazioni sull'argomento che stiamo trattando. Il porporato attinse infatti a una fonte di immenso valore, che altrimenti sarebbe andata perduta. Vi si dice che le regioni montane dell'Occitania erano infestate da felloni, ossia da banditi che mettevano a ferro e a fuoco le ricche cittadine costiere. Controllavano le valli e imponevano pesanti tributi ai mercanti di passaggio, che a causa loro disertavano la regione impedendo lo stabilirsi di proficui traffici. Da ciò possiamo trarre conclusioni interessanti.
Non era infrequente che i mercanti fossero presi in ostaggio e sottoposti a terribili abusi, anche sessuali. Secondo un'ipotesi, il termine fellone (in occitano FEL, plurale FELON, FELO) sarebbe infatti una traduzione del latino irrumator. I costumi di queste genti erano sfrenati come la loro aggressività: rapivano le donne che suscitavano i loro istinti e questo generava una spirale senza fine di vendette e di uccisioni. Dai dati in nostro possesso, si può immaginare che questo fosse il desolante scenario agli inizi del XII secolo, prima dell'apparire dei missionari Catari. I Buoni Uomini destarono l'ammirazione dei felloni, per il semplice fatto che non possedevano nulla. La loro santità fu rispettata al punto che divennero presto oggetto di venerazione. Nel giro di pochi anni, e persino l'arcivescovo pisano lascia trasparire la sua ammirazione, riuscirono a convertire intere vallate facendovi cessare le razzie. I mercanti poterono riprendere in loro viaggi e le loro attività senza eccessivi rischi, così i commerci tornarono a fiorire portando un grande flusso di ricchezza in tutta la Linguadoca. Possiamo credere che il Papato bramasse questa abbondanza, anche se le ragioni che lo indussero ad organizzare una tremenda guerra genocida furono dettate dai più viscerali tra i sentimenti: ODIO E TERRORE.