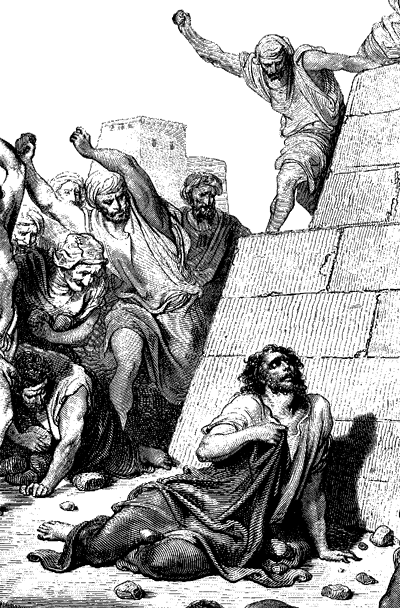Tra le più strane e interessanti parole sarde che mi sia capitato di incontrare, posso annoverare sicuramente il campidanese nea "aurora, alba". Come c'era da aspettarsi, il tentativo di spiegare questo vocabolo erratico ha fatto impazzire gli studiosi.
Così il Salvioni:
CAMPID. néa AURORA
Non vedo altra via per dichiarar la voce, che di invocare ēōs, riconoscendo nel n un resto della preposizione in concresciuta, e nell' -a, un facile metaplasma.
Una simile invocazione è più stupida degli escrementi di una mosca su uno specchio di un postribolo d'infimo ordine.
Salvioni invoca addirittura il greco epico ἠώς (ēṓs) "aurora", nemmeno il greco attico ἕως (héōs). E come diavolo avrebbe fatto una forma antiquata e dotta come quella ad arrivare tra i pastori del Campidano?
Questo è l'elenco degli esiti del proto-indoeuropeo *h₂éwsōs "aurora" negli antichi dialetti della lingua dell'Ellade.
Epico: ἠώς (ēṓs)
trascrizione IPA: /e:'o:s/
Attico: ἕως (héōs)
trascrizione IPA: /'heo:s/
Eolico: αὔως (áuōs), ᾱ̓́ϝως (ā´wōs)
trascrizione IPA: /'auo:s/, /'a:wo:s/
Dorico: ᾱ̓ώς (āṓs)
trascrizione IPA: /a:'o:s/
Beotico: ᾱ̓́ας (ā´as)
trascrizione IPA: /'a:as/
Laconico: ᾱ̓ϝώρ (āwṓr), αβώρ (abṓr)
trascrizione IPA: /a:'wo:r/, /a:'bo:r/
Possiamo essere sicuri che nessuna di queste varianti avrebbe trovato la sua via nell'impervia Sardegna. I romanisti, quando si trovano davanti una voce che non deriva da una trafila di una protoforma latina, vanno in marasma, perché gli schemi che hanno appreso non riescono a sorreggerli. In queste condizioni critiche, troppo spesso proferiscono scemenze!
Tra l'altro, all'epoca in cui le genti di Bisanzio avevano contatti con la Sardegna, l'antico nome dell'aurora era stato sostituito da un'altra parola, αὐγή (augḗ).
αὐγή (augḗ) f. (genitivo αὐγῆς); prima declinazione
1. luce del sole
2. raggi del sole (plurale)
3. aurora, alba
4. luce splendente (come quella del fuoco)
5. riflesso sulla superficie di oggetti splendenti
In greco antico la pronuncia era /au'ge:/, mentre in greco bizantino si era già evoluta in /avˈʝi/.
I Neogrammatici sostengono che questo nome dell'aurora derivi dalla ben nota e produttiva radice indoeuropea *h₂ewg- "crescere, accrescere", da cui sono discese anche le parole latine augēre "crescere" (augeō "io cresco", augēs "tu cresci", auxī "io crebbi", auctum "essendo cresciuto"), augmen "aumento, crescita" e augustus "maestoso, venerabile".
Non sono convinto dell'esattezza di questa ipotesi, nata da una grossolana applicazione del Rasoio di Occam. A parer mio ci sono le basi per postulare una radice indoeuropea omofona di *h₂ewg- "crescere, accrescere", ma indipendente: *h₂ewg- "raggio di sole", "splendore", con paralleli anche extra-indoeuropei (vedi nel seguito).
Altri esiti indoeuropei di *h₂ewg- "raggio di sole":
Albanese: ag "aurora"
< proto-albanese *(h)aug-
agòj "albeggiare, fare giorno"
Proto-slavo: *ju:gu "sud", "vento del sud"
Slavo ecclesiastico: *jugŭ "meridione, sud",
"vento del sud"
Russo: юг (jug) "sud"
Ucraino: юга (juhá) "vento caldo del sud"
Serbo: ју̏г (jȕg) "sud"
Croato: jȕg "sud"
Sloveno: jȕg "sud"
Polacco: jug "disgelo" (dialettale)
Ceco: jih "sud"
Slovacco: juh "sud"
Nemmeno il greco αὐγή può essere l'origine della parola campidanese.
Le opinioni di Pittau
Pittau sosteneva che il sardo campidanese nea "aurora" fosse un grecismo, ma non lo identificava con l'antico nome della Dea Eos: lo confrontava invece con il greco νέα ἡμέρα (néa hēméra) "nuovo giorno". La pronuncia in greco moderno è /'nea i'mera/.
Ben noto è il quotidiano Νέα Ημέρα Τεργέστης (Néa Iméra Tergestis), ossia "Nuovo Giorno di Trieste" (fine XIX secolo - inizi XX secolo).
Ancora una volta, riesce difficile comprendere tutti i passaggi. Ci saremmo aspettati che dalla locuzione greca derivasse in campidanese *neamera, *neimera o *nemera anziché semplicemente nea.
Un possibile prestito dal ligure
La soluzione più ovvia e razionale, quella di un termine proveniente dal sostrato pre-romano, a quanto pare non è stata mai nemmeno considerata. Lo reputo un grave errore, nato dal pregiudizio che offusca la visione e impedisce di conoscere. Procediamo per gradi.
Il greco νέος (néos) "nuovo" e il latino novus "nuovo" hanno la stessa origine, come anche il gallico novio- "nuovo" (attestato ad esempio in Noviomagus "Campo Nuovo", etc.). Queste parole risalgono tutte alla stessa radice:
Proto-indoeuropeo: *newos, *newyos "nuovo"
La lingua degli antichi Liguri era indoeuropea, anche se con un sostrato lessicale più antico. Il concetto di "nuovo" era espresso dall'aggettivo *nevios, come provato da importanti documenti.
L'idronimo ligure Neviasca è attestato nella Tavola bronzea di Polcevera, scritta in latino arcaico e risalente al 117 avanti Cristo, che ci conserva toponimi notevolissimi. Riporto in questa sede il brano che ci interessa (i grassetti sono miei):
Langatium fineis agri privati: ab rivo infimo, qui oritur ab fontei in Mannicelo ad flovium / Edem: ibi terminus stat; inde flovio suso vorsum in flovium Lemurim; inde flovio Lemuri susum usque ad rivom Comberane(am); / inde rivo Comberanea susum usque ad comvalem Caeptiemam: ibi termina duo stant circum viam Postumiam; ex eis terminis recta / regione in rivo Vendupale; ex rivo Vindupale in flovium Neviascam; inde dorsum flovio Neviasca in flovium Procoberam; inde / flovio Procoberam deorsum usque ad rivom Vinelascam infumum: ibei terminus stat; inde sursum rivo recto Vinelesca: / ibei terminus stat propter viam Postumiam, inde alter trans viam Postumiam terminus stat; ex eo termino, quei stat / trans viam Postumiam, recta regione in fontem in Manicelum; inde deorsum rivo, quei oritur ab fonte en Manicelo, / ad terminum, quei stat ad flovium Edem.
Traduzione (di Agostino Giustiniani):
"I confini dell'agro privato dei Langati: presso il fiume Ede, dove finisce il rivo che nasce dalla fonte in Manicelo, qui sta un termine. Quindi si va su per il fiume Lemuri fino al rivo Comberanea. Di qui su per il rivo Comberanea fino alla Convalle Ceptiema. Qui sono eretti due termini presso la via Postumia. Da questi termini, in direzione retta, al rivo Vindupale. Dal rivo Vindupale al fiume Neviasca. Poi di qui già per il fiume Neviasca fino al fiume Procobera. Quindi già per il Procobera fino al punto ove finisce il rivo Vinelasca; qui vi è un termine. Di qui direttamente su per il rivo Vinelasca; qui è un termine presso la via Postumia e poi un altro termine esiste al di là della via. Dal termine che sta al di là della via Postumia, in linea retta alla fonte in Manicelo. Quindi già per il rivo che nasce dalla fonte in Manicelo sino al termine che sta presso il fiume Ede."
L'idronimo Neviasca significa qualcosa come "quella del (luogo) nuovo".
La radice ligure in questione, ha formato almeno un toponimo oltre al nome di fiume sopra considerato. Nell'entroterra genovese, in Val Graveglia, si trova il piccolo borgo di Ne (pronuncia /nɛ/, con la vocale aperta). I romanisti hanno tentato di ricondurlo all'antroponimo Nevius, da loro considerato "romano" - e confuso col gentilizio Naevius. Molto peggio dei romanisti hanno fatto i latinisti d'accatto pullulanti nelle parrocchie ottocentesce e novecentesche. Alcuni di loro hanno preso il latino nāvis "nave" e lo hanno fatto diventare Ne, incuranti del fatto che in genovese ha dato nae. Altri hanno preso il latino nemus "bosco sacro" e lo hanno fatto diventare Ne, incuranti del fatto che la consonante -m- intervocalica non può dileguarsi nel latino volgare che ha dato il genovese. Questi escrementi concettuali, che dovrebbero stare sepolti in una fossa settica, sono stati esumati da Google e messi sotto il naso degli utenti.
Ne deriva direttamente dal ligure *Neviom "(Luogo) Nuovo" (pronuncia /'newiom/).
Propongo così la ricostruzione *nevia /'newia:/ "cosa nuova", che tra i vari significati doveva avere anche "inizio del giorno".
Sappiamo che alcuni elementi indoeuropei di provenienza ligure si sono insinuati nel paleosardo (Blasco Ferrer, 2011). Ad esempio il sardo tevele "debbio", elemento di sostrato, è derivato in ultima analisi dal ligure *debelo- (Debelus fundus) < protoindoeuropeo *dheghw- "bruciare". Così è plausibile che si sia verificata questa trafila:
ligure /'newia:/ > paleosardo /'neia/ > /'nea/.
Decisamente meglio delle storture dei romanisti!
Altra proposta etimologica per nea "aurora"
Quando sono venuto a conoscenza della parola campidanese nea "aurora", la mente mi è andata subito al basco egun "giorno", derivato dal verbo proto-basco *e-gun-i "splendere" (detto del sole). La protoforma ricostruibile sarebbe dunque n-egu-a. Tuttavia mi è sembrata troppo contorta e insoddisfacente la derivazione, carente soprattutto dal punto di vista morfologico: trovavo difficoltà a spiegare l'iniziale n- e la terminazione -a (considerato che questa non può essere l'articolo basco -a, il cui antenato suonava diversamente). Così ho abbandonato questa etimologia.
Conclusioni
Un annoso problema è stato finalmente risolto. Peccato che al mondo accademico non importerà mai nulla di tutto questo: basta che una cosa sia scritta su un blog e la considerano automaticamente immondizia, senza nemmeno leggerla.