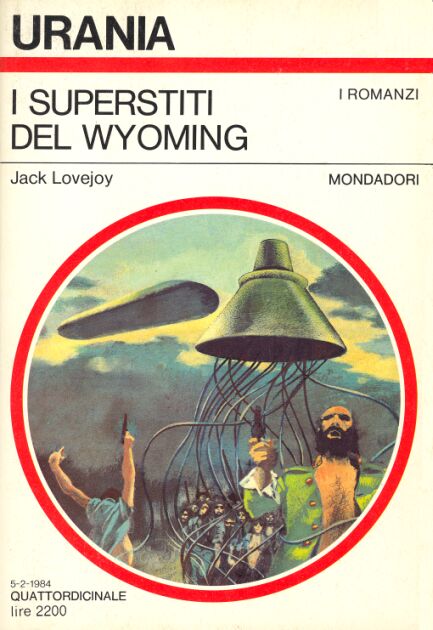Ancora oggi il greco Hyttenia (Ὑττηνία), antico nome di Tetrapolis, è usato come argomento per assegnare al numerale etrusco huθ il valore di "quattro", immaginando che il toponimo più recente traduca alla lettera il più antico. Ho già espresso una serie di opinioni sull'argomento, ma ora, approfondendolo, aggiungo qualche nota ulteriore.
Quello che è sfuggito finora a tutti è che secondo la tradizione a fondare la lega Hyttenia è stato l'eroe Hyttenios (Ὑττήνιος). Ne emerge la somma improbabilità di una traduzione letterale Tetrapolis, visto che non si può interpretare l'eponimo pre-greco servendosi di un toponimo ellenico: si tratta di due categorie concettuali disomogenee.
Non si può nemmeno pensare a una creazione artificiale, un eponimo fittizio inventato per spiegare un toponimo: questo Hyttenios svolgeva un ruolo di primo piano nelle tradizioni locali. Così si legge nel Calendario dei Sacrifici di Maratona (American Journal of Archaeology 10, 209-226):
Nel mese Skiraphorion, prima della <festa> Skira. A Hyttenios, frutti di stagione, una pecora, dodici dracme. A Kourotrophos, un maiale, tre dracme, una porzione sacerdotale, due dracme, un obolo. Ai Tritopateres, una pecora, una porzione sacerdotale, due dracme. Agli Akamantes, una pecora, dodici dracme, una porzione sacerdotale, due dracme.
Come risulta ovvio, nessuno si sognerebbe mai di fare offerte sacrificali in memoria di un eroe fittizio inventato da un dotto per spiegare un nome di luogo. Qui si tratta addirittura di una figura divinizzata. Che i sostenitori dell'argomento Hyttenia se ne facciano una ragione: Hyttenios è reale e ben fondato nella tradizione attica.
Come mai finora questo eponimo Hyttenios non era mai saltato fuori in nessuna trattazione etruscologica? Queste sono le risposte:
1) Disonestà intellettuale di colui che per primo ha proposto l'argomento;
2) Copiatura pedissequa da parte di coloro che hanno ripetuto l'informazione (un vizio insidioso che può colpire chiunque e che non mi ha certo risparmiato);
3) Inerzia mentale di chi non ha mai approfondito la questione cercando le notizie disponibili, foss'anche nel Web (anche questa è un'insidia sempre in agguato, da cui nessuno è immune).
Di fronte a Hyttenios dovremmo porci allora la seguente domanda: da dove viene questo antroponimo?
Data la natura dell'aspirazione che in greco classico precede sempre la vocale υ e le impedisce di iniziare la parola, e data la trasformazione di un'originaria sibilante in aspirazione, ci sono tre possibilità:
1) *UTTE:NIO- / *UTTA:NIO-
2) *HUTTE:NIO- / *HUTTA:NIO-
(con h- confrontabile con lo stesso suono in tirrenico)
3) *SUTTE:NIO- / *SUTTA:NIO-
Quale delle tre? Come si vede, l'argomento Hyttenia - Tetrapolis è a dir poco labile.
Se valesse la ricostruzione 2) e la radice fosse tirrenica, allora sarebbe addirittura possibile che un antroponimo *HUTTENI- significasse "Sesto Nato" (in etrusco abbiamo hutni- "sesta parte, un sesto", attestato nel Liber Linteus).
Questo è un buon metodo: diffidare delle assonanze, sempre, e approfondire ogni suggerimento. Occorre attuare procedure di verifica che integrino dati linguistici ed extralinguistici. Curioso che i "seminatori di dubbi" tanto diffusi nel Web mostrino poi una fede cieca proprio nelle assonanze e nelle baggianate cabalistiche.